Complesso del Foran del Muss
Elenco cavità componenti il complesso
Morfometria complesso
Cavità componenti il complesso 16
Sviluppo planimetrico: rilevato 15783,2 m stimato 0 m
Sviluppo spaziale: rilevato 19972 m stimato 0 m
Dislivello totale/profondità: rilevato 1115 m stimato 0 m
Quota ingresso più alto (s.l.m.) 2016 m
Quota fondo 901 m
Disegni
31/12/2002 - Alessandro Mosetti - GTS - Gruppo Triestino Speleologi
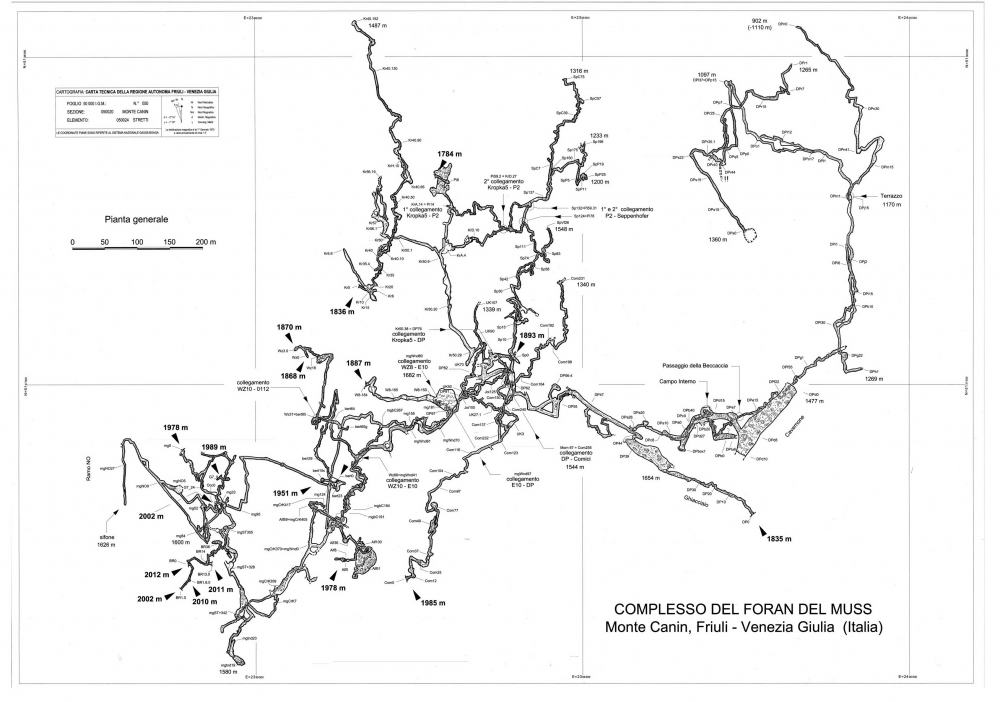
Planimetria complesso (2012)
31/12/2002 - Alessandro Mosetti - GTS - Gruppo Triestino Speleologi
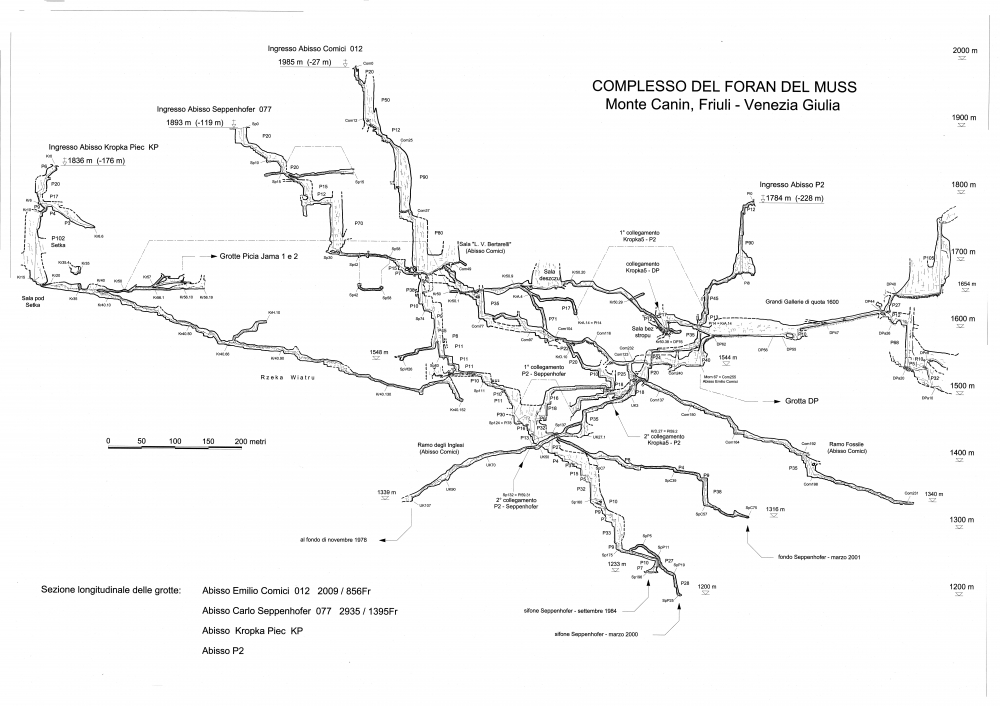
Sezione longitudinale delle grotte: Abisso Emilio Comici (2009), abisso Carlo Seppenhofer (2935), Abisso Kropka Piec (KP), Abisso P2
31/12/2002 - Alessandro Mosetti - GTS - Gruppo Triestino Speleologi
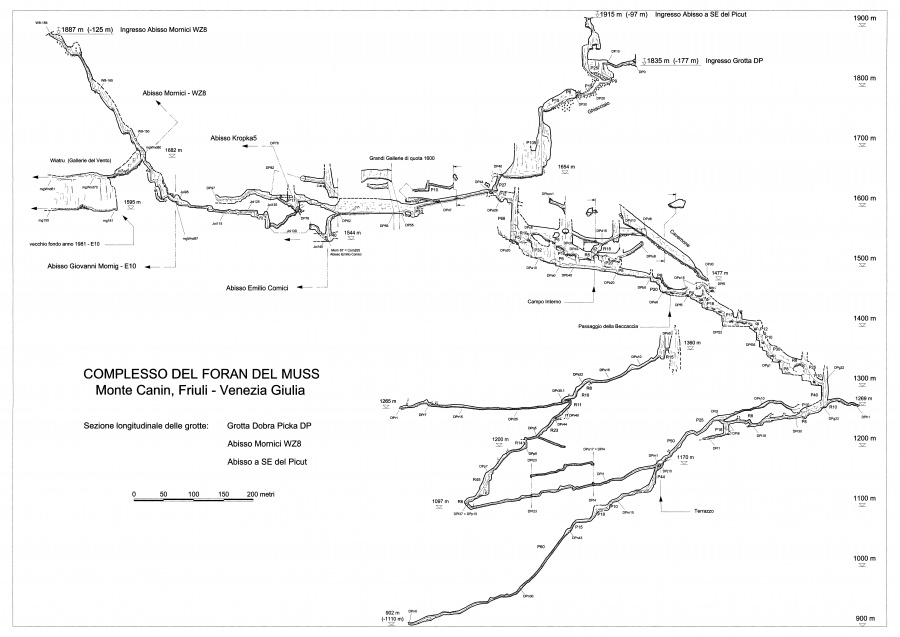
Sezione longitudinale delle grotte: Dobra Picka (DP) Abisso Mornici Abisso a SE del Picut
31/12/2002 - Alessandro Mosetti - GTS - Gruppo Triestino Speleologi
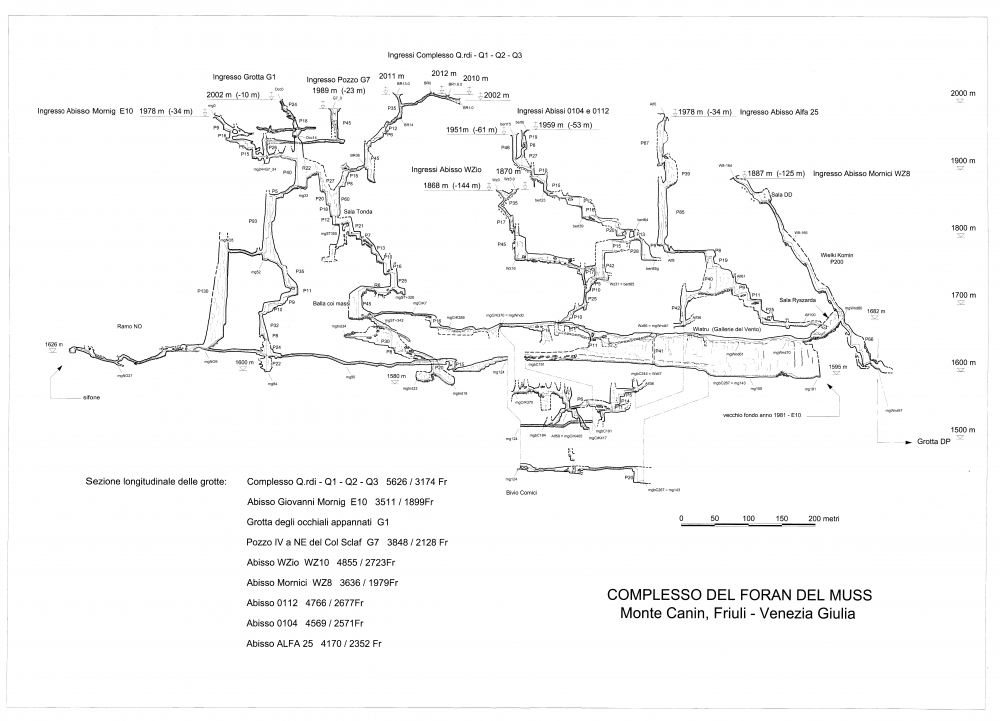
Sezione longitudinale
Annotazioni
Il Complesso del Foran del Muss è una grotta ad andamento misto con le morfologie tipiche degli abissi d’alta quota, essendo costituita da diversi livelli di condotte freatiche (sia abbandonate dalle acque che attive) tagliate da ambienti ad andamento verticale e da forre strutturali.
Il condizionamento tettonico nella genesi di queste morfologie è evidente: i grandi pozzi si sono formati in corrispondenza di discontinuità verticali persistenti (in genere una o due), i tratti orizzontali invece sono spesso stati guidati dalla stratificazione.
Caratteristica principale è la coesistenza di morfologie freatiche e vadose alla stessa quota, indizio che gli ambienti del Complesso non hanno avuto un’origine unica e consequenziale, ma sono il risultato di più fasi evolutive e di diverse condizioni idrogeologiche.
Di particolare interesse è l’analisi della distribuzione altimetrica dei livelli di condotte originatesi in condizioni freatiche o epifreatiche e che hanno permesso di effettuare i numerosi collegamenti tra grotte con ingressi differenti .
Il Foran del Muss è interessato da tre livelli distinti di gallerie, il più alto a quote intorno ai 1.800 m, l’intermedio alla quota di 1.600 m e il più basso, corrispondente al livello tuttora attivo, a quote inferiori Le gallerie poste a quota 1.800 m s.l.m. sono meno continue e sviluppate: queste condotte si sono probabilmente formate lungo brevi tratti di trasferimento orizzontale dell’acqua e appartenenti a una zona di generale trasferimento verticale delle acque in ambiente vadoso.
Nella loro genesi assume particolare importanza la presenza di discontinuità sub orizzontali (spesso piani di strato) che guidano il deflusso idrico, ad esempio tra due pozzi cascata impostati su fratture verticali.
Le gallerie poste a quota 1.600 m s.l.m. sono più sviluppate e regolari. Attraversano tutto il Complesso del Foran del Muss in senso W-E, presentano spesso sezioni rotondeggianti con diametri fino a 10 m, sono intersecate da svariati ambienti di origine vadosa evidentemente più giovani, e talora sono dislocate da faglie riprese da movimenti recenti. Si tratta di una delle morfologie più antiche di tutto il Canin, collegate a un antico livello di base precedente all’erosione glaciale e post glaciale della Val Raccolana e generate in probabili condizioni climatiche e morfologiche diverse dalle attuali.
I tratti orizzontali posti al di sotto di quota 1.200 s.l.m., in realtà non sono definiti da una quota netta in quanto l’andamento delle gallerie risulta a tratti influenzato dall’inclinazione degli strati (anche 15°). Si sviluppano 50-100 metri sopra il passaggio stratigrafico tra i Calcari del Dachstein e la Dolomia Principale, caratterizzato da una fascia di calcari dolomitici. È lecito pensare che la genesi di queste forme sia legata a un limite di carsificabilità definito, piuttosto che a una zona satura vera e propria. Durante le piene più significative queste zone vengono allagate in quanto le dimensioni dei vani non riescono a smaltire rapidamente gli apporti idrici.
Il fondo della grotta DP arriva al contatto con la Dolomia Principale, dove gli ambienti ipogei sono condizionati da inter- strati e fratture allargate da processi prevalentemente erosivi piuttosto che dissolutivi.
Cavità componenti il complesso
Bibliografia
Pino Guidi e Aurelio Pavanello
Circolo Speleologico e Idrologico Friulano - Udine, Provincia di Udine - Assessorato all'Ambiente (2011)
Biblioteca del CSR
Collocazione: In "Il fenomeno carsico delle Alpi Giulie" Mem. Ist. It. Spel., s. II, vol. XXIV, 2011, pp. 37-41.
Categorie: Speleologia tecnica
Indici: Incidenti e soccorso
Keyword: Incidente
Nell'articolo è riportato un incidente avvenuto presso l'Abisso Mornig
Fabio Stoch
Circolo Speleologico e Idrologico Friulano - Udine, Provincia di Udine - Assessorato all'Ambiente (2011)
Biblioteca del CSR
Collocazione: In
Link: https://www.csif.it/Archivi/CSIF/PDF/0000/350.PDF
Categorie: Biospeleologia
Indici: Fauna
Keyword: Fauna, Animali
Fauna locale
Maurizio Tavagnutti (1975)
Biblioteca del CSR
Collocazione: Atti del primo convegno di speleologia del Friuli Venezia Giulia 8-9 dicembre 1973
Categorie: Speleologia tecnica
Indici: Esplorazioni
Keyword: Esplorazione, Carso, ricerca
Descrizione speleologica sull' abisso "Emilio Comici".
Alessandro Mosetti
Gruppo triestino speleologi (1992)
Collocazione: Bollettino del gruppo triestino speleologi N.12/92
Categorie: Documentazione speleologica, Speleologia tecnica
Indici: Esplorazioni, Guide e narrativa
Keyword: esplorazioni, scoperta, Abisso Mornig, Canin
L'articolo descrive l'abisso Mornig e le fasi esplorative.
gianni benedetti e alessandro mosetti
gruppo triestino speleologi (1985)
Biblioteca del CSR
Collocazione: BOLLETTINO DEL GRUPPO TRIESTINO SPELEOLOGI VOLUME 5
Categorie: Documentazione speleologica
Indici: Cartografia, Fotografia, Guide e narrativa
Keyword: abisso, esplorazioni
storia, descrizioni e curiosità di alcune grotte
Gianni Benedetti
Gruppo Triestino Speleologi (1991)
Biblioteca del CSR
Collocazione: Bollettino del gruppo triestino speleologi N. 11/91
Categorie: Documentazione speleologica, Speleologia tecnica
Indici: Esplorazioni
Keyword: Storia, Esplorazioni, Descrizione
Storia delle esplorazioni e descrizione con alcune misure dimensionali e della temperatura.
M. Tavagnutti
Società Speleologica Italiana (1980)
Biblioteca del CSR
Collocazione: in "Speleologia" n. 4, Rivista della società speleologica italiana
Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_04_Dic_1980 OCR.pdf
Categorie: Speleologia tecnica
Indici: Esplorazioni
Keyword: esplorazione
Note sull'esplorazione fino a profondità di 375 metri e scoperta dell'ingresso laterale
Paolo Guglia e Franco Gherlizza
Società Speleologica italiana (1981)
Biblioteca del CSR
Collocazione: "Speleologia" n. 6, Rivista della società speleologica italiana
Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_06_Dic_1981 OCR.pdf
Categorie: Documentazione speleologica, Speleologia tecnica
Indici: Esplorazioni, Guide e narrativa
Keyword: esplorazioni, scoperta, Abisso Mornig, Canin
Note sulle esplorazioni e descrizione della cavità.
Giacomo Casagrande
Circolo Speleologico e Idrologico Friulano - Udine, Provincia di Udine - Assessorato all'Ambiente (2011)
Biblioteca del CSR
Collocazione: In
Link: https://www.csif.it/Archivi/CSIF/PDF/0000/350.PDF
Categorie: Geospeleologia e carsismo
Indici: Geomorfologia e speleogenesi
Keyword: Evoluzione geomorfologica, Speleogenesi
Breve descrizione delle cavità a nord ovest del massiccio del Canin trattando aspetti storici e descrittivi e analisi dell'evoluzione geomorfologica
Franco Gherlizza
Federazione Speleologica Triestina (1998)
Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2012/02/AnnuarioSoccorso_1998_WEB.pdf
Categorie: Speleologia tecnica
Indici: Incidenti e soccorso
Keyword: Incidente, soccorso, infortunio
Breve descrizione dell’incidente avvenuto in questa cavità il 3 novembre 1974
Gianni Benedetti
Società Speleologica Italiana (1984) (1984)
Biblioteca del CSR
Collocazione: “Speleologia” n.10, Rivista della società speleologica italiana
Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_10_Gen_1984 OCR.pdf
Categorie: Speleologia tecnica
Indici: Esplorazioni
Keyword: Occlusione di ghiaccio, avventura
Resoconto dell'esplorazione
Franco Gherlizza
Federazione Speleologica Triestina (1998)
Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2012/02/AnnuarioSoccorso_1998_WEB.pdf
Categorie: Speleologia tecnica
Indici: Incidenti e soccorso
Keyword: incidenti, soccorso, Canin
Tullio Ferluga
Commissione grotte Eugenio Boegan (1979)
Biblioteca del CSR
Collocazione: Progressione n.4
Link: http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2017/08/Progressione_004.pdf
Categorie: Documentazione speleologica
Indici: Guide e narrativa
Keyword: foran del muss, abisso
Descrizione ingresso e ubicazione
M.B.T.
Commissione grotte Eugenio Boegan (1980)
Biblioteca del CSR
Collocazione: Progressione n.6
Link: http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2017/08/Progressione_006.pdf
Categorie: Speleologia tecnica
Indici: Esplorazioni
Keyword: esplorazioni, profondità
Nuova profondità raggiunta.
Casagrande G., Mosetti A., Zamparo G.
Federazione Speleologica Regionale del FVG (1999)
Collocazione: in Atti dell’Vili Convegno Regionale del Friuli- Venezia Giulia, Federazione Speleologica Regionale del FVG, Trieste
Categorie: Documentazione speleologica, Geospeleologia e carsismo
G. Benedetti e A. Mosetti
Società Speleologica Italiana (2000)
Collocazione: in "Speleologia" n. 42
Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_42_Nov_2000 OCR.pdf
Categorie: Documentazione speleologica
Keyword: Geomorfologia, Idrologia, Storia esplorativa, Foran del Muss, Monte Canin
Il Foran del Muss rappresenta una delle varie zone carsiche del Massiccio del M. Canin (Friuli-Venezia Giulia - Italia). Dai primi anni ’70 vi si compiono esplorazioni speleologiche che hanno portato alla scoperta di vari profondi abissi indi- pendenti (Ab. Comici, Ab. Seppenhofer, Ab. Momig, ecc.). Dagli anni ’90, a seguito di un primo collegamento (Ab. Viva Zio-Ab. Momig) gli esploratori, principalmente della Regione, hanno iniziato un lavoro sistematico al fine di collegare i vari abissi dell’area. Dopo una decina d’anni, grazie anche alle scoperte fatte da speleologi polacchi con i quali si è instaurato un rapporto di collabo- razione, è stato possibile formare un complesso ipogeo che per il momento conta 23 ingressi, oltre 15 km di sviluppo planimetrico e 1.110 metri di profondità.
Alessandro Mosetti
Società Speleologica Italiana (2017)
Link: http://www.speleologiassi.it/76-dobra-picka-2017/
Categorie: Documentazione speleologica
Indici: Cinematografia e filmati
Keyword: video
Il video testimonia il campo interno del 2017.
Ulteriore link:
https://youtu.be/jk90Rr2t6dA
S-Team
S-Team (2012)
Link: http://www.speleo-team.it/2012/08/dobra-picka-in-canin.html
Categorie: Documentazione speleologica
Indici: Articoli online e siti web
Keyword: Fotografie
Resoconto di un'uscita fotografica.
Fotografie
Graziano Cancian
Museo Friulano di Storia Naturale, Udine (2015)
Collocazione: Gortania, 37(2015), pp. 33-63, Udine,1.XII.2016 ISSN: 2038-0410
Link: http://www.civicimuseiudine.it/images/MFSN/Gortania/Gortania 37_GPP/G37_gpp_Cancian_LR.pdf
Categorie: Geospeleologia e carsismo
Indici: Depositi sotterranei, riempimenti, speleotemi
Nell’articolo vengono riportate le caratteristiche di 43 minerali di grotta finora identificati nel Friuli Venezia Giulia. Sono compresi in queste classi: ossidi e idrossidi, carbonati, solfati, fosfati, silicati. Le principali scoperte sono state effettuate a partire dal 1984, grazie soprattutto all’uso della diffrattometria a raggi X. Alcuni ritrovamenti sono stati i primi in Italia. Queste ricerche hanno dimostrato che nelle grotte sono presenti più fasi mineralogiche di quanto si ritenesse in passato. Il ritrovamento di questi minerali, pertanto, porta un utile contributo alla conoscenza del carsismo sotterraneo, poiché sono il prodotto di reazioni chimiche qui avvenute, inoltre, spesso sono stabili solo in determinate condizioni ambientali
Marek Koziol (1998)
Collocazione: Jaskinie - The Caves, issue 10 (3/1998)
Link: http://www.sktj.pl/epimenides/jaskinie/jask10.html
Categorie: Documentazione speleologica, Speleologia tecnica
Indici: Esplorazioni
Benedetti G.
Società Speleologica Italiana (1996)
Collocazione: Spelelogia 35
Categorie: Documentazione speleologica
Gianni Benedetti
Gruppo Triestino Speleologi (1984)
Collocazione: Bollettino del Gruppo Triestino Spel., 4,
Categorie: Documentazione speleologica
AA.VV.
G.G. Treviso (1994)
Collocazione: Spelaion, Boll. del G.G. Treviso
Categorie: Documentazione speleologica
Trevisani Claudio (1994)
Collocazione: Spelaion 4, pagg. 51-53 (bolletino del Gruppo Grotte Treviso)
Categorie: Documentazione speleologica
T. Barnabei e M. Campion
Giorgio Vivalda (1993)
Collocazione: Alp, 9, 98: 30-31,
Categorie: Documentazione speleologica
Nota sulle esplorazioni susseguitesi nella conca del Foran del Muss ed incentrate su vari tronconi del sistema che confluisce nell'abisso Mornig, alla ricerca del collettore più profondo. L'ultimo atto della ricerca è l'esplorazione dell'Abisso dei Dannati (K 12), sceso sino a -385.
M.
Scintilena (2012)
Link: https://www.scintilena.com/k12-abisso-dei-dannati-complesso-foran-del-muss-udine/10/02/
Categorie: Documentazione speleologica
Indici: Articoli online e siti web
Campion M.
G.G. Treviso (1994)
Collocazione: Spelaion, Boll. del G. G. Treviso, 4: 60.
Categorie: Documentazione speleologica
Dati catastali e breve descrizione dell'ingresso alto del complesso E10 -W ZIO (dislivello m 202, lunghezza m 400).
A. Mosetti
Gruppo Triestino Speleologi (1991)
Collocazione: Bollettino del Gruppo Triestino Spel., 11: 13-18,
Categorie: Documentazione speleologica
Storia delle esplorazioni, descrizione, note morfologiche, foto e rilievo
Gianni Benedetti
Gruppo Grotte dell'Ass. XXX Ottobre (1993)
Collocazione: Annali del Gruppo Grotte dell'Ass. XXX Ottobre, 8: 33-39
Categorie: Documentazione speleologica
Gianni Benedetti e Fabrizio Viezzoli
Società Speleologica Italiana (1991)
Collocazione: Speleologia, 12, 24: 73-74,
Categorie: Documentazione speleologica
Storia delle esplorazioni, durate undici anni (1980-1990), che hanno portato al collegamento dell'Ab. IV del Picut (W Zio) con l'Ab. Mornig.
Bagliani Furio, Gherlizza Franco, Nussdorfer Giacomo (1981)
Collocazione: Atti del V Conv. Reg. di Spel. del Friuli-Venezia Giulia,
Categorie: Geospeleologia e carsismo
Cenni geologici sulla zona e breve descrizione della cavità sino alla profondità di 482 metri.
Giacomo Nussdorfer (1983)
Collocazione: Atti del Convegno Int. sul Carso di Alta Montagna, Imperia aprile-maggio 1982,
Categorie: Geospeleologia e carsismo


