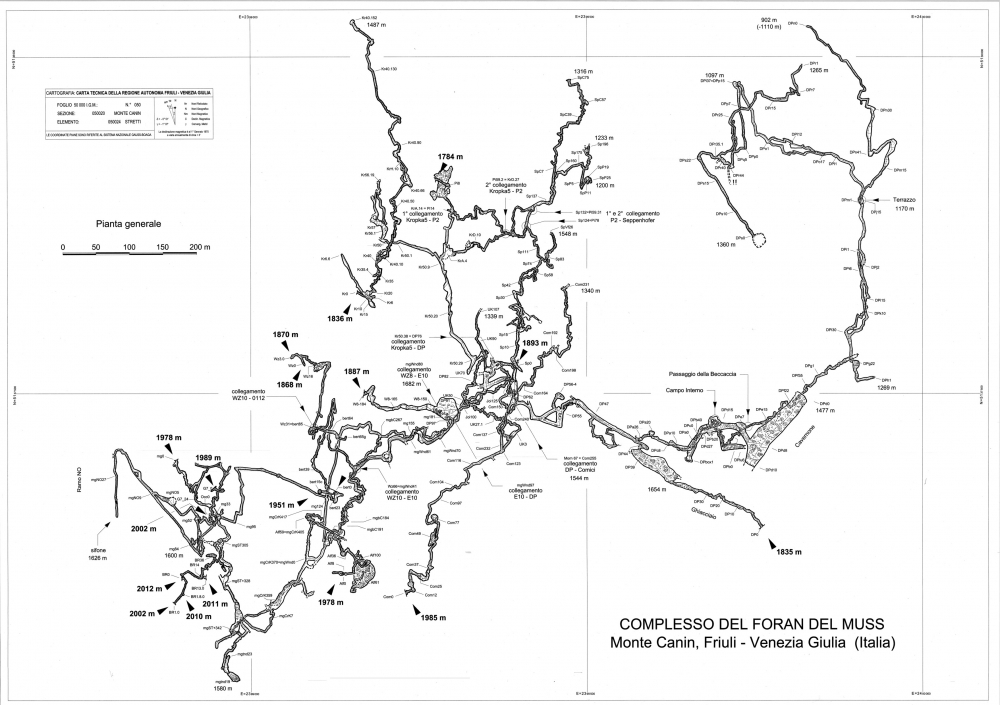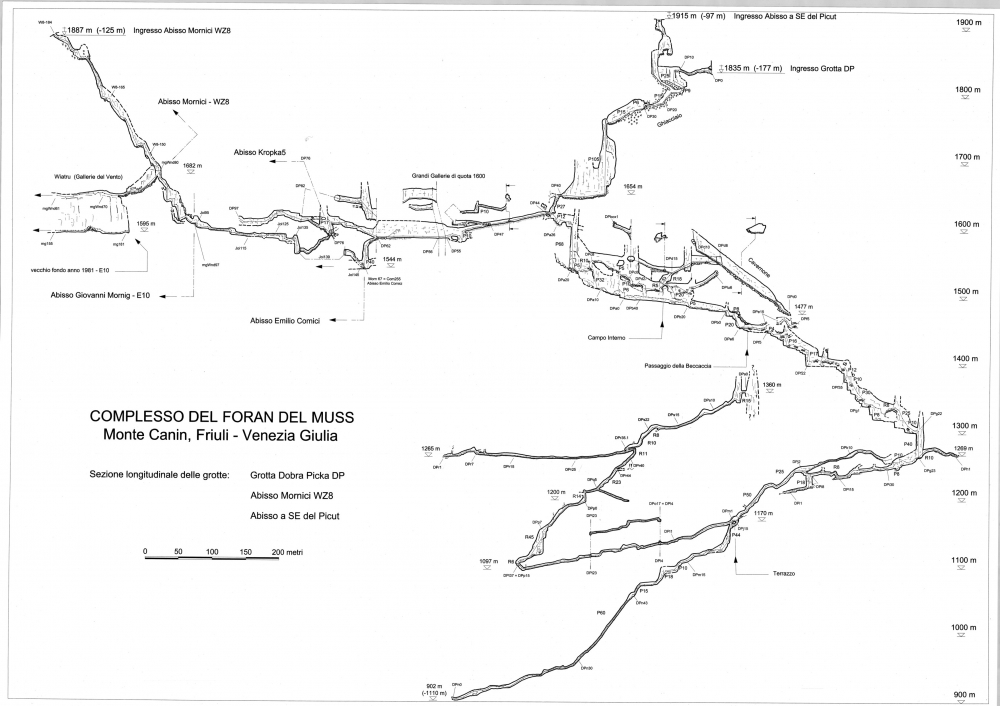Nome principale: Dobra P
Numero catasto: 7780
Numero catasto locale: 4751FR
Numero totale ingressi: 1
Data primo accatastamento: 20/07/2016
Data scoperta: 01/01/1996
Scopritore: Giacomo Zamparo
Gruppo scopritore: FJ - Associazione Speleologica Forum Julii Speleo
Data scoperta: 01/01/1996
Scopritore: Moreno Dorigo
Gruppo scopritore: SACILE - Gruppo Speleologico Sacile
Descrizione ingresso
Numero ingresso: 1
Nome ingresso: Ingresso 1
Ingresso principale: Si
Sigla ingresso: DP
Stato ingresso: Agibile
Tipo ingresso: Orizzontale
Morfologia ingresso: Fessura
Pericoli all'accesso: Nessuno
Limitazioni: Nessuna
Accessibilità: Libera
Targhettatura
Presenza targhetta: No
Località
Comune: Chiusaforte
Area geografica: Alpi Giulie
Area provinciale: Udine
Tipo carta: 1:5.000
Carta CTRN 1:5.000: 050024 - Stretti
Rilevamento posizione
Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS
Tipo posizione: Prima Posizione
Tipo coordinate rilevate: Metriche Gauss-Boaga - Fuso Est
Latitudine: 5137302
Longitudine: 2399760
Lat. WGS84: 46,37838797
Lon. WGS84: 13,43640177
Est RDN2008/UTM 33N: 379755,627
Nord RDN2008/UTM 33N: 5137278,277
Data esecuzione posizione: 01/01/2011
Quota ingresso (s.l.m.): 1835 m
Metodo rilevamento quota: Altimetro
Carta utilizzata: 1:5.000
Affidabilità posizione: Corretto
Autori della posizione
Autore: Alessandro Mosetti
Gruppo appartenenza: GTS - Gruppo Triestino Speleologi
Caratteristiche
Sviluppo planimetrico: 5419 m
Sviluppo spaziale: 6697 m
Dislivello positivo: 4 m
Profondità: 934 m
Dislivello totale: 938 m
Quota fondo: 901 m
Andamento cavità: Misto
Stato della cavità
Esplorazione in corso: Si Prosecuzioni: Presenza di prosecuzioni accessibili Presenza rami: Si Grotta turistica: No
Meteorologia ipogea
Danneggiamenti
Non sono presenti informazioni
Geologia
fonte: Carta geologica del Friuli Venezia Giulia alla scala 1:150.000
Litologia: Carbonati, talora con marne, stratificati
Ambiente: Piattaforma carbonatica, di margine e di rampa
Età: Giurassico inf.
| Formazione: | Calcare di Stolaz, Calcari a Crinoidi |
Non sono presenti informazioni
Vincoli
Nome ramo: Principale alle giunzioni
Numero ramo: 1
Descrizione ramo:
Ramo attivo: No
Pozzo/risalita/scivolo
| Tipo | Dislivello | Nome |
|---|---|---|
| Pozzo | 25 m | |
| Pozzo | 9 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 15 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 6 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 15 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 105 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 27 m | Arrivo gallerie |
| Arrivo gallerie | ||
| Pozzo | 10 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 17 m | NULL |
| NULL |
Nome ramo: DP_MORN
Numero ramo: 2
Descrizione ramo:
Ramo attivo: No
Pozzo/risalita/scivolo
| Tipo | Dislivello | Nome |
|---|---|---|
| Pozzo | 40 m |
Nome ramo: DPCONLAT
Numero ramo: 3
Descrizione ramo:
Ramo attivo: No
Pozzo/risalita/scivolo
| Tipo | Dislivello | Nome |
|---|---|---|
| Pozzo | 10 m |
Nome ramo: DPBIVUP1
Numero ramo: 4
Descrizione ramo:
Ramo attivo: No
Pozzo/risalita/scivolo
| Tipo | Dislivello | Nome |
|---|---|---|
| Pozzo | 12 m | |
| Pozzo | 68 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 5 m | NULL |
| NULL | ||
| Risalita | 10 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 5 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 10 m | NULL |
| NULL | ||
| Risalita | 5 m | NULL |
| arrivo campo |
Nome ramo: Ai Cavernoni
Numero ramo: 5
Descrizione ramo:
Ramo attivo: No
Pozzo/risalita/scivolo
| Tipo | Dislivello | Nome |
|---|---|---|
| Risalita | 18 m |
Nome ramo: DPBIVDW
Numero ramo: 6
Descrizione ramo:
Ramo attivo: No
Pozzo/risalita/scivolo
| Tipo | Dislivello | Nome |
|---|---|---|
| Pozzo | 36 m | |
| Pozzo | 6 m | NULL |
| Confluenza ramo per il fondo |
Nome ramo: Dal campo verso il fondo
Numero ramo: 7
Descrizione ramo:
Ramo attivo: No
Pozzo/risalita/scivolo
| Tipo | Dislivello | Nome |
|---|---|---|
| Pozzo | 20 m | |
| Pozzo | 5 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 8 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 20 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 4 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 16 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 17 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 12 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 10 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 30 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 8 m | NULL |
| NULL | ||
| Risalita | 8 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 25 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 10 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 40 m | NULL |
| fine forra |
Nome ramo: Ramo al sifoncino
Numero ramo: 8
Descrizione ramo:
Ramo attivo: No
Pozzo/risalita/scivolo
| Tipo | Dislivello | Nome |
|---|---|---|
| Risalita | 10 m |
Nome ramo: Via bassa al terrazzo
Numero ramo: 9
Descrizione ramo:
Ramo attivo: No
Pozzo/risalita/scivolo
| Tipo | Dislivello | Nome |
|---|---|---|
| Pozzo | 10 m | |
| Pozzo | 8 m | NULL |
| NULL | ||
| Risalita | 8 m | NULL |
| NULL |
Nome ramo: Pozzo cieco via bassa
Numero ramo: 10
Descrizione ramo:
Ramo attivo: No
Pozzo/risalita/scivolo
| Tipo | Dislivello | Nome |
|---|---|---|
| Pozzo | 18 m |
Nome ramo: Al terrazzo
Numero ramo: 11
Descrizione ramo:
Ramo attivo: No
Pozzo/risalita/scivolo
| Tipo | Dislivello | Nome |
|---|---|---|
| Pozzo | 25 m | |
| Pozzo | 50 m | NULL |
| arrivo al terrazzo |
Nome ramo: Dal terrazzo al fondo
Numero ramo: 12
Descrizione ramo:
Ramo attivo: No
Pozzo/risalita/scivolo
| Tipo | Dislivello | Nome |
|---|---|---|
| Pozzo | 44 m | |
| Pozzo | 10 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 18 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 15 m | NULL |
| NULL | ||
| Pozzo | 60 m | NULL |
| sifone finala |
Nome ramo: Risalite
Numero ramo: 13
Descrizione ramo:
Ramo attivo: No
Pozzo/risalita/scivolo
| Tipo | Dislivello | Nome |
|---|---|---|
| Risalita | 6 m | |
| Risalita | 45 m | NULL |
| NULL | ||
| Risalita | 14 m | NULL |
| NULL | ||
| Risalita | 23 m | NULL |
| NULL | ||
| Risalita | 11 m | NULL |
| ramo del sifone | ||
| Risalita | 10 m | NULL |
| NULL | ||
| Risalita | 8 m | NULL |
| NULL | ||
| Risalita | 15 m | NULL |
| continua |
Breve descrizione del percorso d'accesso
L'ingresso della grotta è costituito da una stretta e alta fessura verticale che si apre a 1835 m di quota ai piedi della bastionata rocciosa orientata SW-NE che segna il confine orientale del Foran del Muss alla base della quale corre il sentiero CAI n645
Descrizione dei vani interni della cavità
Dall'ingresso alle grandi gallerie dei collegamenti:
la prima parte della grotta si sviluppa lungo un sistema di strette e alte fessure verticali intervallate da alcuni brevi pozzi e scivoli ghiacciati con orientamento ESE-WNW Alla profondità di 30 metri in corrispondenza di un laghetto ghiacciato confluisce da un camino l'ultimo pozzo dell'Abisso a SE del Picut (6141/3528 Fr)
Superata una strettoia segue un ambiente fortemente inclinato largo una decina di metri e alto circa trenta il cui fondo è occupato da un imponente scivolo di ghiaccio dello spessore di qualche decina di metri Nel corso degli ultimi 15 anni il livello del ghiacciaio è calato di circa 5 metri
Segue un pozzo di 105 m che dopo poche decine di metri comunica direttamente con la vasta caverna sottostante i cui assi principali misurano circa 70 m per 30 m
Una strettoia alla base della parete opposta a quella di discesa immette nel successivo pozzo di 27 m Alla sua base superato un basso passaggio con il pavimento di fine terriccio si sbuca nelle seguenti ampie gallerie fossili che misurano circa 5 m di larghezza e 3-4 di altezza incise sul fondo dall'antico approfondimento In una nicchia laterale sono visibili delle rare formazioni eccentriche
Le gallerie orientate sempre rettilinee verso WNW dopo qualche centinaio di metri intersecano un caratteristico specchio di faglia che le ha dislocate di qualche decina di metri verso l'alto
Questa zona molto complessa e labirintica costituisce il nodo di collegamento con l'Abisso Comici (2009/856 Fr) l'Abisso Mornici WZ8 (3636/1979 Fr) l'Abisso Mornig E10 (3511/1899 Fr) e l'Abisso Kropka Piec (non catastato)
Dalla base del P27 (-236m) al P40 (-574m):
superato il basso passaggio alla base del P27 (-236 m dall'ingresso) all'inizio delle grandi gallerie fossili sprofonda un primo salto verticale di 12 m a cui segue un ampio pozzo cascata profondo 68 m In questo pozzo confluisce una diramazione che parte dalla base del P10 a metà delle grandi gallerie fossili dei collegamenti
Alla base del P68 segue una ampia e complessa struttura verticale orientata prima verso SE e quindi verso NE che si può percorrere sia lungo lo stretto meandro del fondo sia risalendo gli ampi vani soprastanti spesso interessati da crolli La via più agevole percorre gli ambienti alti fino a raggiungere un comodo terrazzo a 320 m di profondità dove è stato allestito un piccolo campo interno
Dal campo interno risalendo una R18 e la successiva breve galleria si sfocia nella parte alta di un'ampia caverna larga una trentina di metri e alta una decina che si sviluppa fra i 1570 m e i 1470 m di quota e il cui pavimento è ingombro di grossi massi e detrito
Dal campo interno si ridiscende nella forra che con diversi salti verticali e una breve risalita porta fin sulla sommità di un ampio pozzo profonda 40 m la cui base si trova a 574 m di profondità
Sotto al campo interno in un disagevole e stretto passaggio lungo la forra è stato ritrovato il teschio di una beccaccia
Dalla base del P40 (-574m) al terrazzo prima dei fondi:
dalla base del P40 la grotta cambia morfologia e punta decisamente a Nord percorrendo un sistema di condotte freatiche attive spesso molto ripide che si sviluppano seguendo l'inclinazione degli strati Dopo un salto di 25 m e uno di 50 m si arriva sul terrazzo a 574 m di profondità
Dal terrazzo prima dei fondi al fondo del Complesso:
dal terrazzo a -574 le condotte freatiche attive sprofondano in un pozzo di 44 m cui seguono altre condotte molto ripide o quasi verticali Dopo aver superato una sequenza di scivoli molto inclinati tra i quali un P 60 si entra nella dolomia e dopo pochi metri un piccolo sifone segna il punto più profondo del Complesso a 902 m di quota sul livello del mare (marzo 2000)
Dal terrazzo prima dei fondi alle risalite:
superando il terrazzo a -574 le condotte ora non più percorse dall'acqua puntano verso ENE fino ad arrestarsi a 1097 m di quota alla base di un ampia frattura verticale dalla quale proviene una forte circolazione d'aria e un arrivo d'acqua che si perde tra i detriti del pavimento
Una serie di risalite ha permesso di superare circa 260 m di dislivello percorrendo delle condotte freatiche attive in alcuni tratti Nel punto più alto raggiunto a 1360 m di quota le esplorazioni si sono arrestate a metà di un vasto pozzo attivo la cui base dovrebbe riconfluire attraverso un passaggio impraticabile a metà della R23
A 1270 m di quota si sviluppano circa 200 m di antiche condotte freatiche il cui pavimento è ingombro di detriti e sedimenti In un punto sono state ritrovate alcune ossa lunghe appartenenti a qualche piccolo mammifero Le gallerie che si sviluppano prevalentemente verso NE terminano a 1265 m di quota in un piccolo sifone d'acqua alimentato da un modesto stillicidio Nel corso di un'esplorazione nel febbraio del 2012 il livello del sifone era sceso di alcuni metri liberando un passaggio inesplorato dal quale entrava una forte corrente d'aria Sulle sponde del sifone sono stati ritrovati piccoli pezzi di legno e un seme germogliato
Data rilievo: 31/12/2002
Tipo rilievo: Primo rilievo
Precisione rilievo: 6
Autori del rilievo
Autore: Alessandro Mosetti
Gruppo appartenenza: GTS - Gruppo Triestino Speleologi
Autore: Giacomo Zamparo
Gruppo appartenenza: FJ - Associazione Speleologica Forum Julii Speleo
Autore: Moreno Dorigo
Gruppo appartenenza: SACILE - Gruppo Speleologico Sacile
Autore: Gianni Benedetti
Gruppo appartenenza: GTS - Gruppo Triestino Speleologi
Autore: Giacomo Casagrande
Gruppo appartenenza: GTS - Gruppo Triestino Speleologi
File rilievi presenti
Tipo file rilievo: Pianta
Note rilievo: intera pianta complesso Foran del Muss
Tipo file rilievo: Sezione
Note rilievo: Sezione Dobra P e giunzioni
Planimetria georiferita
La georeferenziazione della planimetria della cavità è comunque da intendersi indicativa, per l'accuratezza far riferimento alla scheda rilieviData planimetria: 31/12/2002
Accuratezza: Misto
Autori digitalizzazione
Autore: Michele Potleca
Gruppo appartenenza: SGEO - Regione FVG - Servizio geologico
Bibliografia
Casagrande G., Mosetti A., Zamparo G.
Federazione Speleologica Regionale del FVG (1999)
Collocazione: in Atti dell’Vili Convegno Regionale del Friuli- Venezia Giulia, Federazione Speleologica Regionale del FVG, Trieste
Categorie: Documentazione speleologica, Geospeleologia e carsismo
G. Benedetti e A. Mosetti
Società Speleologica Italiana (2000)
Collocazione: in "Speleologia" n. 42
Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_42_Nov_2000 OCR.pdf
Categorie: Documentazione speleologica
Keyword: Geomorfologia, Idrologia, Storia esplorativa, Foran del Muss, Monte Canin
Il Foran del Muss rappresenta una delle varie zone carsiche del Massiccio del M. Canin (Friuli-Venezia Giulia - Italia). Dai primi anni ’70 vi si compiono esplorazioni speleologiche che hanno portato alla scoperta di vari profondi abissi indi- pendenti (Ab. Comici, Ab. Seppenhofer, Ab. Momig, ecc.). Dagli anni ’90, a seguito di un primo collegamento (Ab. Viva Zio-Ab. Momig) gli esploratori, principalmente della Regione, hanno iniziato un lavoro sistematico al fine di collegare i vari abissi dell’area. Dopo una decina d’anni, grazie anche alle scoperte fatte da speleologi polacchi con i quali si è instaurato un rapporto di collabo- razione, è stato possibile formare un complesso ipogeo che per il momento conta 23 ingressi, oltre 15 km di sviluppo planimetrico e 1.110 metri di profondità.
Alessandro Mosetti
Società Speleologica Italiana (2017)
Link: http://www.speleologiassi.it/76-dobra-picka-2017/
Categorie: Documentazione speleologica
Indici: Cinematografia e filmati
Keyword: video
Il video testimonia il campo interno del 2017.
Ulteriore link:
https://youtu.be/jk90Rr2t6dA
S-Team
S-Team (2012)
Link: http://www.speleo-team.it/2012/08/dobra-picka-in-canin.html
Categorie: Documentazione speleologica
Indici: Articoli online e siti web
Keyword: Fotografie
Resoconto di un'uscita fotografica.
Fotografie
Graziano Cancian
Museo Friulano di Storia Naturale, Udine (2015)
Collocazione: Gortania, 37(2015), pp. 33-63, Udine,1.XII.2016 ISSN: 2038-0410
Link: http://www.civicimuseiudine.it/images/MFSN/Gortania/Gortania 37_GPP/G37_gpp_Cancian_LR.pdf
Categorie: Geospeleologia e carsismo
Indici: Depositi sotterranei, riempimenti, speleotemi
Nell’articolo vengono riportate le caratteristiche di 43 minerali di grotta finora identificati nel Friuli Venezia Giulia. Sono compresi in queste classi: ossidi e idrossidi, carbonati, solfati, fosfati, silicati. Le principali scoperte sono state effettuate a partire dal 1984, grazie soprattutto all’uso della diffrattometria a raggi X. Alcuni ritrovamenti sono stati i primi in Italia. Queste ricerche hanno dimostrato che nelle grotte sono presenti più fasi mineralogiche di quanto si ritenesse in passato. Il ritrovamento di questi minerali, pertanto, porta un utile contributo alla conoscenza del carsismo sotterraneo, poiché sono il prodotto di reazioni chimiche qui avvenute, inoltre, spesso sono stabili solo in determinate condizioni ambientali
Agenda
Non sono presenti informazioni