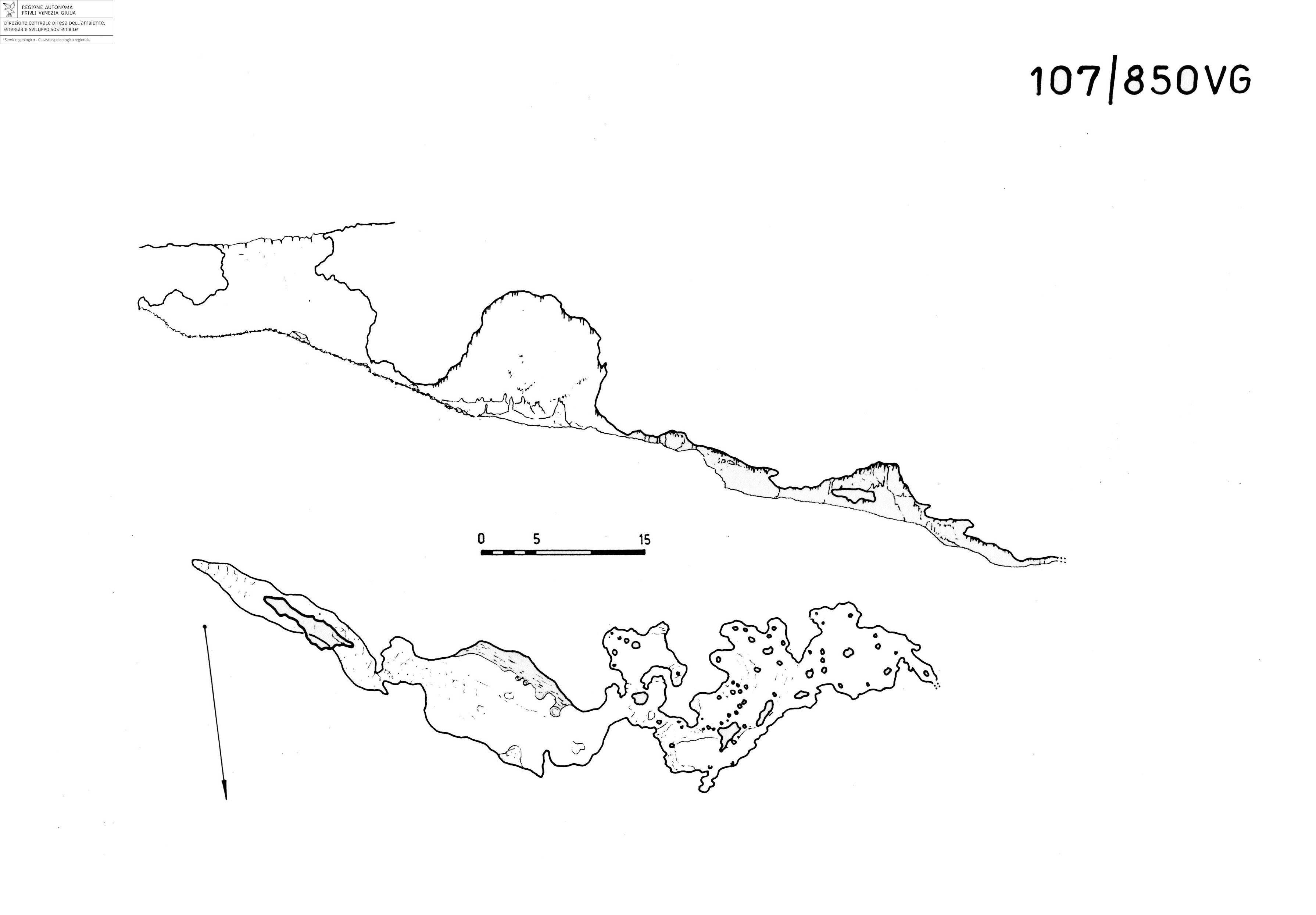Nomi e numeri catastali
Nome principale: Grotta Romana
Numero catasto: 107
Numero catasto locale: 850VG
Numero totale ingressi: 1
Caratteristiche
Sviluppo planimetrico: 91 m
Profondità: 30 m
Dislivello totale: 30 m
Quota fondo: 228 m
Ingresso principale
Presenza targhetta: No
Area geografica: Carso Triestino
Comune: Sgonico / Zgonik
Area provinciale: Trieste
Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS differenziale
Lat. WGS84: 45,73353646
Lon. WGS84: 13,73760756
Est RDN2008/UTM 33N: 401782.061
Nord RDN2008/UTM 33N: 5065217.152
Quota ingresso (s.l.m.): 258 m
Geologia e Geomorfologia
Caratteri fisiografici
Ubicazione: Carso
Area carsica: Carso (A)
Caratteri interni
Andamento: Tratti verticali e orizzontali alternati
Pozzi: No
Ampiezza piano calpestabile: m
Grotta turistica: No
Acqua interna: No
Note caratteri interni:
Ingressi
Ingresso 1
Lat. WGS84: 45,73353646
Lon. WGS84: 13,73760756
Quota ingresso: 258 m s.l.m.
Archeologia
Data
1892-1897?Autore
Karl Moser, Andrea Perko, Amerigo HoffmanConservati
NoPubblicati
-Note
Moser visitò la grotta il 14 febbraio 1892 accompagnato dai suoi studenti (Flego, Župančič 2012, p. 160), uno dei quali, Perko, vi effettuò 8 esplorazioni complessivamente in tempi peraltro non precisati (Perko 1897, p. 46).Indagine
Tipologia di indagine: recupero
Area indagine: parziale
Settore: I sala
Strato: Superficie
Cronologia: Preistoria
Materiali
Ceramici: manufatti di impasto grossolano decorati con impressioni digitali.
Litici: manufatti non determinati in selce, tra cui 1 punta di freccia.
Paleontologici: ossi e denti di mammiferi; conchiglie marine.
Osso/Corno: punteruoli
Bibliografia: Battaglia 1926
Data
1893Autore
Giovanni Andrea PerkoConservati
NoPubblicati
SiIndagine
Tipologia di indagine: recupero
Area indagine: parziale
Settore: I e II sala
Strato: Superficie
Cronologia: Età romana
Materiali
Ceramici: urne non meglio determinate (I sala); lucerne (bacino d'acqua della II sala).
Metallici: 2 spilloni a testa globulare; 3 anelli; 2 bottoni; 2 fibule; 1 gancio di cinturone; 1 frammento di coltello; 1 placca discoidale decorata; alcune monete non determinate (tutti i bronzi - alcuni spezzati intenzionalmente - provengono dal bacino d'acqua della II sala).
Bibliografia: Perko 1897; Battaglia 1926; Durigon 1999
Note
Tuttora sulla superficie di calpestio della grotta sono presenti numerosi frammenti di anfore.Descrizione e rilievo
Breve descrizione del percorso d'accesso
La grotta è situata tra i paesi di Gabrovizza e Sgonico, a 50 metri ad Est della Jama Cotariowa (151/264VG), a circa 200m NW dalla strada carrozzabile che porta a Sgonico. Il suo imbocco si apre tra nudi banchi calcarei formati da calcare radiolitico principale.
Descrizione dei vani interni della cavità
La cavità ha inizio con una caratteristica fenditura frastagliata dalla quale sprofonda un breve baratro dalle pareti estremamente irregolari. poi un tratto ripido dalla volta bassa introduce in una caverna spaziosa, dove la parete Sud si presenta rivestita da panneggi e colate calcitiche che scendono verso un gruppo di tozze stalagmiti; alla sua estremità ha inizio un lungo passaggio malagevole che termina alla sommità di uno scivolo con una stretta bifora. Dal vano sottostante vari pertugi aperti in un'estesa barriera formata da colonne di ogni grandezza danno accesso ad un'altra caverna alquanto più piccola della precedente, ma molto ricca di concrezioni; poi la cavità continua ancora con una breve galleria in discesa e termina con un cunicolo che diviene presto impraticabile.
La Grotta Romana deve il suo nome al rinvenimento di alcuni oggetti di bronzo di epoca romana, avvenuta nel 1893 ad opera di Perco in un bacino d'acqua tuttora esistente in una cavernetta laterale; secondo il Battaglia si tratta di una stipe votiva del periodo veneto. Numerosi cocci romani e preistorici vennero raccolti inoltre, assieme ad ossa di animali, nello scarso terriccio nerastro della prima sala.
Attualmente le concrezioni, un tempo belle ed abbondantissime, appaiono molto danneggiate ed ovunque si notano le tracce del passaggio dei numerosi visitatori. E'da rilevare infine che parte degli ambienti sotterranei si sviluppa sotto alla vicina Jama Cotariowa.
NOTA:
la grotta è stata catastata successivamente con il numero 990 VG, che deve ritenersi pertanto annullato.
Bibliografia
Dante Cannarella
Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia (1999)
Biblioteca del CSR
Collocazione: Atti dell' VIII convegno di speleologia del FVG (pp. 67-76)
Categorie: Antropospeleologia
Indici: Archeologia
Keyword: resti romani, anelli, gemme di cristallo
Si tratta di una bella cavità, con un largo pozzo di accesso profondo otto metri. I primi scopritori vi trovarono numerosi oggetti di bronzo di epoca romana. Recentemente sono stati ritrovate una decina di sferette di argento, due semisfere usate come borchie e due anelli.
Marzolini G.
Gruppo Grotte dell’Associazione XXX Ottobre (1998)
Collocazione: Annali del Gruppo Grotte dell’Associazione XXX Ottobre, 10: 115-118, Trieste
Link: https://www.axxxo.net/annali-vol-x-1998/
Categorie: Antropospeleologia
Indici: Archeologia
Nuovi ritrovamenti di numerosi frammenti di anfore confermano che la grotta venne frequentata in modo regolare in epoca romana.
Hoffmann A. (1892)
Collocazione: Argo, 1: 76-78, Laibach (Ljubljana SLO)
Categorie: Antropospeleologia
Indici: Archeologia
L'autore nel descrivere la grotta Romana da lui esporata nel 1892 fa cenno alla scoperta di alcuni resti ossei.
Moser L.K. (1899)
Collocazione: Schimpff editore, 129 pp., Trieste
Categorie: Antropospeleologia
Indici: Archeologia
Descrizione delle ricerche compiute da Moser in numerose cavità del Carso triestino.
Battaglia R. (1955)
Collocazione: In: Atti del V Congr. Naz. di Spel., Salerno ottobre 1951, 63-78, Salerno
Categorie: Antropospeleologia
Indici: Archeologia
L'A., dopo premesse di carattere generale sul popolamento umano nelle cavità nel corso della Preistoria (qui definite come "abitati trogloditici") , descrive lo stato delle conoscenze sugli insediamenti umani allora noti nelle cavità italiane, discussi in senso cronologico (dal Paleolitico Inferiore al Medioevo) e geografico. Tra i contesti regionali si sottolinea il primato della regione Venezia Giulia per l'elevato numero di cavità esplorate e abitate in antico